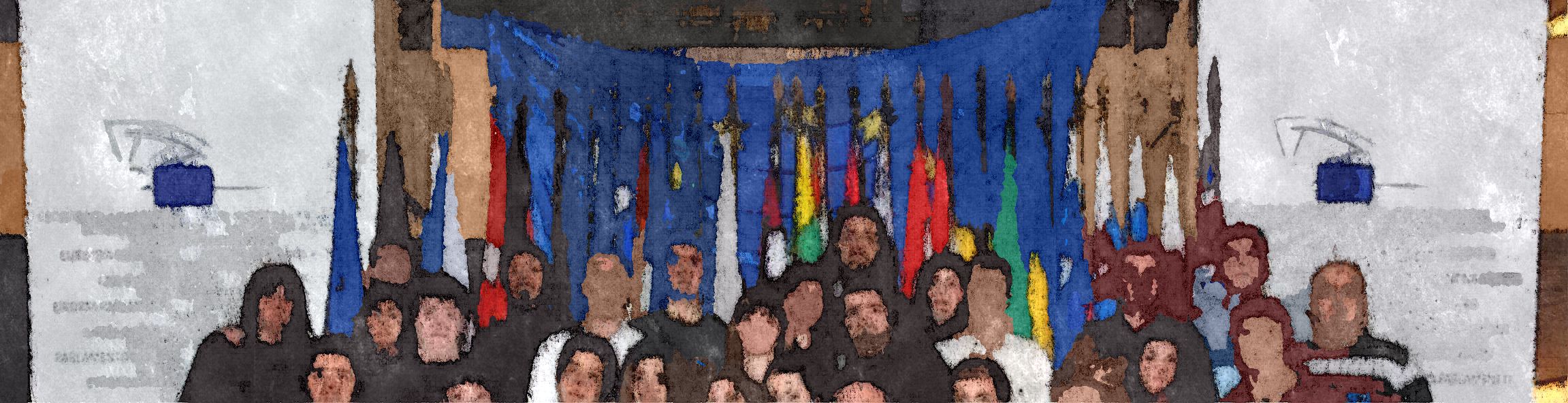
Rassegna Stampa
Senza democratizzare il processo, l’unificazione dell’Europa rimane senza incomprensibile e senza legittimità popolare
Jürgen Habermas
Lunedì 12 Marzo 2012 – Reset online (http://www.reset.it)
Nel processo dell’integrazione europea vanno distinti due piani. L’integrazione degli Stati affronta il problema di come ripartire competenze tra l’Unione da un lato e gli Stati membri dall’altro. Questa integrazione riguarda dunque l’ampliamento di potere delle istituzioni europee. Invece l’integrazione dei cittadini riguarda la qualità democratica di questo crescente potere, ossia la misura in cui i cittadini possono partecipare al fine di decidere i problemi dell’Europa. Per la prima volta dall’istituzione del Parlamento europeo, il cosiddetto fiscal compact che si sta varando in queste settimane (per una parte dell’Unione) serve a far crescere l’integrazione statale senza una corrispondente crescita dell’integrazione civica dei cittadini.
Certo, il carattere astrattamente tecnocratico caratterizzante ab origine la politica europea rimanda alla sua nascita storica. L’unificazione fu spinta avanti dai governi e non dai popoli: associandosi sul piano economico-giuridico, i cittadini restavano soggetti di diritto privato. Solo a partire dal 1979 si formò un Parlamento europeo dotato di potere legislativo – un Parlamento che nel corso degli ultimi tre decenni ha visto progressivamente aumentare le sue competenze. Da quel momento, sul piano europeo, i cittadini del mercato economico diventano anche cittadini di una Unione politica, e la comunità economica diventa finalmente una vera comunità politica (ancorché in termini nominali assai più che sostanziali). Non diversamente dalla Commissione e dal Consiglio, anche il Parlamento opera su un piano astrattamente tecnico. Infatti, il percorso della legittimazione che va dai cittadini al loro Parlamento viene lasciato inutilizzato e incolto. Neppure in occasione delle elezioni europee questo spazio viene esplorato: queste elezioni continuano a essere dominate da agende di tipo strettamente nazionale. Il deficit democratico è sempre stato presente. Ma adesso, dopo anni d’impotenti risposte politiche alla crisi del debito provocate dalle banche, siamo costretti a chiederci «se sia ancora occultabile questo deficit di legittimità, quando l’Unione – nel cercare una soluzione politica alla crisi monetaria – si vede costretta a fare appello a quelle risorse di solidarietà che l’approccio tecnocratico ha sempre compresso».
Con queste parole, Hauke Brunkhorst sottolinea giustamente la dimensione politica in cui andrà in ultima istanza trovata una soluzione alla crisi finanziaria. La tesi che vorrei difendere in questa sede è presto detta. Solo una discussione democratica che affronti a trecentosessanta gradi il futuro comune della nostra cittadinanza europea potrebbe produrre decisioni politicamente credibili, capaci cioè di imporsi ai mercati finanziari e agli speculatori che puntano sulla bancarotta degli Stati. L’eurogruppo si sforza invano di «corteggiare» i mercati finanziari invocandone sempre di nuovo la «fiducia». Ma questo accade solo perché nessuno lo prende sul serio. I governi non hanno la forza di corroborare con i fatti le loro disorientate decisioni. Agiscono spinti dalla necessità, cercando di nascondere agli occhi delle clientele elettorali di casa loro le conseguenze politiche degli accordi firmati a Bruxelles. In realtà, per essere credibili agli occhi della speculazione, i capi di governo dovrebbero prima – tutti insieme – disegnare una prospettiva di lungo termine sul futuro della comunità monetaria, e poi difenderla con impegno per guadagnarsi il consenso delle rispettive sfere pubbliche nazionali. Ma gli opportunisti del potere non vogliono correre questi rischi, limitandosi a strategie di breve respiro: di fronte a un passo simile arretrano spaventati come il diavolo davanti all’acqua santa.
Certo, anche i partiti del nostro Bundestag rischierebbero costi non indifferenti, ove si decidessero a trasferire l’elitario progetto europeo, finora calato dall’alto sulle popolazioni, dentro una chiassosa e polarizzante partecipazione dei cittadini. Ma per neutralizzare il populismo scettico delle destre non basta più rimasticare i luoghi comuni del buonismo europeista. Finora, pur cercando di armonizzare accortamente (quanto meno nell’eurozona) le loro politiche fiscali ed economiche, gli Stati membri non sono andati al di là di retoriche proclamazioni. L’integrazione degli Stati diventerà credibile solo quando potrà appoggiarsi a una integrazione dei cittadini in cui si manifestino maggioranze dichiaratamente pro-europee. In caso contrario, la politica non riguadagnerà più la sua autonomia nei confronti delle agenzie di rating, grandi banche e hedgefonds. Gettare nell’arena politica questo tema scottante di dibattito può essere un azzardo. Ma ancor più rischioso è il poker che Angela Merkel sta giocando con i mercati finanziari.
Dal mio punto di vista, sul piano della politica europea, il governo tedesco sta facendo poche cose giuste e molte cose sbagliate. Lo slogan «Più Europa» è la risposta giusta a una crisi dovuta a un difetto di costruzione della comunità monetaria. La politica non riesce più a compensare gli squilibri economici che ne sono nati. Sul lungo periodo, il riassetto dei divergenti sviluppi economico-nazionali è realizzabile solo in termini di collaborazione, nel quadro di una responsabilità democraticamente organizzata e condivisa, capace di legittimare anche un certo grado di redistribuzione che oltrepassi le frontiere nazionali. Da questo punto di vista, il fiscal compact è certamente un passo nella direzione giusta. Fin dalla sua definizione ufficiale – Trattato «per la stabilità, l’armonizzazione e la governance» – si vede come questo patto sia costituito da due diversi elementi. Esso obbliga i governi per un verso a rispettare le discipline di bilancio nazionali, per l’altro verso a istituzionalizzare una «governance» di politica economica avente per obiettivo di eliminare gli scompensi economici (quanto meno nell’eurozona).
Come mai però Angela Merkel festeggia solo la prima parte del patto, quella mirante a penalizzare le infrazioni di bilancio, mentre non spende una parola sulla seconda parte, mirante a una concertazione politica della «governance» economica? Ammesso, e non concesso, che si possa tranquillizzare sul breve periodo i mercati semplicemente annunciando una restrizione del debito con adeguate procedure di rientro, le crisi sono certo destinate a ripetersi sul lungo periodo, finché non si sarà corretto l’errore che ha viziato dalle origini la costruzione della comunità monetaria. Nel quadro di una stessa valuta, gli eccessi di esportazione dovuti a bassi costi di produzione e gli eccessi di importazione dovuti ad alti costi di produzione sono strettamente connessi. Per equilibrare i livelli di concorrenzialità, non basta che i diversi governi si attengano alle stesse regole. Il governo tedesco, pur riconoscendo a parole il bisogno di una integrazione ulteriore, di fatto contribuisce a lasciar marcire la crisi.
A questo riguardo mi limito a quattro brevi considerazioni. In primo luogo non occorre farla lunga, in termini di politica economica, per capire che una politica restrittiva unilaterale, come quella caldeggiata nella Ue dal governo tedesco, spinge nella deflazione i paesi più sofferenti. Ove non si integrino le politiche restrittive con politiche di sviluppo, la «pace sociale» delle nazioni poste sotto tutela finirà per essere disturbata non soltanto dai pacifici e ordinati cortei dei sindacati. In secondo luogo, la politica restrittiva risponde all’idea sbagliata secondo cui tutto si risolverà nel momento in cui gli Stati membri sapranno accettare questo nuovo patto di stabilità e crescita. Di qui la fissazione di Angela Merkel nel voler imporre sanzioni: una postura minacciosa assolutamente superflua nel momento in cui si riuscisse a inserire nella legislazione ordinaria della Ue una «governance» economica condivisa. Continua invece a imperversare l’idea per cui basterebbe istituire una «giusta» costituzione economica – dunque «regole» sovratemporali – per risparmiarci le fatiche di una concertazione politico-economica nonché i costi derivanti da una legittimazione democratica dei programmi di redistribuzione.
In terzo luogo, Merkel e Sarkozy operano sostanzialmente sul piano di una politica intergovernativa, mirando a spingere avanti, senza troppo rumore, l’integrazione degli Stati e non quella dei cittadini. I capi di governo dei 17 paesi rappresentati nel Consiglio dei ministri dovrebbero tenere in pugno il bastone di comando. Sennonché, una volta dotati delle competenze di «governance» economica, essi svuoterebbero la sovranità economica dei parlamenti nazionali. La conseguenza sarebbe un rafforzamento post-democratico degli esecutivi, dalle conseguenze imprevedibili. Allora, l’inevitabile protesta dei parlamenti spodestati avrebbe almeno il vantaggio di portare in luce quel «deficit di legittimazione» che solo una riforma democratica degli organi di governo comunitari potrà colmare. In quarto luogo, le parole d’ordine del governo tedesco in fatto di bilancio suscitano all’estero il sospetto che la Germania federale persegua mire nazionalistiche.
«Nessuna solidarietà, se prima non si garantisce stabilità» (Keine Solidarität ohne Solidität). La proposta lanciata da Berlino di mandare un commissario plenipotenziario ad Atene – dove già ci sono, con analoghe funzioni di controllo, tre commissari appena giunti dalla Germania – dimostra un’incredibile insensibilità nei confronti di un paese in cui non si è ancora spento il ricordo delle efferatezze compiute dalle SS e dalla «Wehrmacht». Helmut Schmidt, in un appassionato discorso, ha deplorato che il governo attuale stia dilapidando il prezioso capitale di fiducia che la Germania si era guadagnata presso i vicini nel corso degli ultimi cinquant’anni.
L’impressione generale – che si ricava da questa sciocca arroganza, per un verso, e dalla troppo timida risposta al ricatto dei mercati finanziari, per l’altro – è che la politica europea non abbia ancora raggiunto il livello di una vera «politica interna». Nel suo ruolo di presidente del partito cristiano-democratico, Angela Merkel ammonisce continuamente se stessa come cancelliera: così, temendo lo scetticismo dei suoi elettori, decide di mantenere a «fuoco basso» il processo d’integrazione. E proprio nel paese cui spetta oggi una funzione-guida, il filo-europeismo si riduce a uno slogan supplichevole: «lavatemi ma non bagnatemi!».
Come sperare, in queste condizioni, che negli altri paesi la discussione pubblica sull’Europa ne risulti incoraggiata? Queste prudenze non sono neppure giustificabili dal vecchio argomento secondo cui l’integrazione è destinata a fallire per mancanza di un popolo europeo e di una sfera pubblica europea. Nelle idee di «nazione» e di «popolo» avevamo a che fare con fantastici soggetti omogenei: ideali che solo nel corso dell’Ottocento, canalizzati dalle scuole pubbliche e dai mass media, si erano impadroniti dell’immaginario popolare.
Sennonché le catastrofi del XX secolo non hanno lasciato indenni le ideologie storiografiche dei vari nazionalismi. Oggi l’Europa deve fare i conti non tanto con «popoli» illusoriamente omogenei, quanto piuttosto con Stati-nazione concreti, con una pluralità di lingue e di sfere pubbliche. Pur associandosi sempre più strettamente sul piano europeo, gli Stati nazionali conservano funzioni specifiche. Essi non devono affatto dissolversi in uno Stato federale d’Europa, ma conservare un ruolo di garanzia per i livelli di democrazia e di libertà fortunatamente già raggiunti.
Ciascuno di noi unisce in petto due ruoli: quello di cittadino del proprio Stato e quello di cittadino dell’Unione. E nella misura in cui i cittadini dell’Unione capiranno quanto profondamente le decisioni europee modificano la loro vita, tanto più si sentiranno coinvolti in una politica europea che può anche chiedere di spartire sacrifici. Ciò che manca sono sfere pubbliche nazionali capaci di produrre dibattiti e volontà collettive sui temi europei.
Per questo non ci sarebbe bisogno di nuovi media; basterebbe un uso diverso dei media esistenti. Questi non dovrebbero limitarsi a elencare i comuni temi europei, ma dovrebbero anche illustrare le opposte soluzioni agitate all’interno dei diversi paesi. La sfera pubblica europea non è altro che la somma delle sfere pubbliche nazionali, una volta che queste si siano reciprocamente aperte l’una all’altra. Ciò risolverebbe automaticamente anche il problema del pluralismo linguistico: toccherebbe infatti agli stessi media il compito di provvedere alla traduzione. Nelle redazioni dei giornali vige ancora una visione di tipo statal-nazionale. E la stampa tedesca condivide il tiepido filo-europeismo di una cancelliera bravissima a temporeggiare.
Sennonché proprio questa percezione statal-nazionale della società mondiale e dei suoi problemi deve anche prendere atto che – nel concerto di potenze indiscutibilmente mondiali come Usa, Cina, Russia, Brasile o India – la crisi demografica sta ora spingendo l’Europa delle micro-nazioni ai margini della storia mondiale, privandola di ogni residua facoltà d’intervento. Si dice che la repubblica di Weimar sia fallita perché i suoi difensori democratici erano troppo pochi. Fallirà l’Unione europea per i troppi sostenitori troppo tiepidi?
(traduzione di Leonardo Ceppa e Walter Privitera)







Nessun commento pubblicato