
Da “Blog Romualdica” – 09 Luglio 2012
San-Romualdo: «Non credete ai distruttori delle regole che parlano in nome dell’amore.
Là dove la regola è frantumata, l’amore abortisce». (Gustave Thibon)
________
Oggi molti – anche cristiani – si beffano davanti a coloro che osano ancora dire che bisogna rifare il mondo. Come se la maturità – e soprattutto la maturità della fede – significano un sano e realistico distaccamento dalle utopie che parlano di cambiare il mondo e, piuttosto, di una serena accettazione del mondo così com’è. In tal caso la fede cristiana consiste in una sorta di scienza del buon vivere, o, se vogliamo, una etica del buon vivere, seguendo l’esempio dei santi, facendo il possibile almeno per migliorare, al massimo, quel piccolo spazio di mondo in cui ognuno vive. Ma se al cristianesimo togliamo le grandi visioni di futuro, il sogno che cambiare il mondo è non solo possibile, ma è costitutivo della missione stessa della vocazione cristiana, cosa resta della fede? La grande promessa dei cieli nuovi e di una terra nuova non sono un mondo “altro”, qualcosa che non dipende dal lavoro dell’uomo. E’ il compimento di una promessa di Dio, che solo in Dio si può realizzare, che è dono… puro dono di Dio… non mera opera umana. Ma qui sta il mistero della vocazione cristiana: questa promessa è affidata anche alle mani dell’uomo. Mediante la sua fede, la speranza e la carità egli anticipa la realizzazione di quel mondo futuro. E così egli realizza la grande utopia di rifare il mondo. La vera questione è che per rifare il mondo, nel mondo in cui viviamo, occorre cominciare dalle profondità del proprio mondo interiore. E’ lì che bisogna ricominciare… perché l’Interiorità dell’uomo è il pilastro su cui regge l’opera di ricostruzione dell’intero mondo. tentare di ricostruire il mondo a partire da qualsiasi altro punto, oggi, di fronte a una crisi antropologica e spirituale così radicale, è come tentare di innalzare un grattacielo partendo dai piani alti, e aspettandosi che questi si reggano da soli, autosospesi nel vuoto, in attesa che si finisca di costruire le fondamenta per poi ricongiugerle con questi. E’ un’impresa impossibile. (E.C.)
________
Introduzione
Due parole riassumono magnificamente la spiritualità monastica del XII secolo: Magnitudo, grandezza dell’uomo immagine di Dio, e rectitudo, lo sforzo necessario di rettitudine dopo la caduta nel peccato originale. La parola regola, che ha la stessa radice di rectitudo, non ha una buona fama, salvo tra i monaci benedettini che vedono nella Regola del loro patriarca un monumento di saggezza e l’espressione santissima della volontà di Dio.
Vittime da due secoli di una falsa filosofia, abbiamo finito per vedere nella regola un intralcio alla libertà, quando invece ne è la condizione stessa. Quarant’anni fa Gustave Thibon aveva lanciato questo terribile avvertimento: «Disprezzi le regole, le tradizioni e i dogmi. Non vuoi imporre nessun inquadramento dottrinale al tuo bambino, al tuo discepolo; benissimo. Gli dai da bere un vino prezioso, dimentichi solo di dargli una coppa; cos’è il vino senza coppa? Un ruscello che cade a terra, ed eccolo versato, produce il peggior fango».
La tradizione militare e l’esperienza del comando testimoniano in favore dell’obbedienza alla regola. Ecco le parole di un ufficiale (capitano André Bridoux, Souvenirs du temps des morts):
«Più la regola è severa, più c’è libertà. Questo si capisce. Un capo sicuro dei suoi subordinati può essere generoso nel concedere favori.
«Si può soffrire qualche volta di essere comandati troppo o male; si soffre ancora di più di non esserlo affatto, perché il disordine si produce subito e la più grande disgrazia pesa allora sui piccoli.
«Questo rispetto della regola stretta porta lontano, e in particolare a una grande severità nei giudizi perché, secondo questo principio, il cavaliere d’Assas non ha fatto che il suo dovere; è meglio appoggiarsi alla perfezione della regola che sull’imperfezione della natura.
«Gli uomini saranno sempre obbligati ad assicurarsi contro sé stessi. La buona volontà non è sufficiente, perché presto si piegherebbe di fronte alla prova ripetuta del pericolo della morte, prima ancora davanti al ripetersi di lavori semplici ma noiosi che riempiono la vita del soldato e che sono tuttavia indispensabili».
Quante anime rimpiangono tardi di non avere saputo serrare la propria vita in un corsetto di ferro di una regola morale esigente! Il suo impiego ragionevole avrebbe loro risparmiato lo spettacolo desolante di un’esistenza senza regole, fatta di mollezza e di pigrizia. «Ah! Se si potesse rifare…», si dicono con un tono toccante. Ma la parola inesorabile del poeta cade come una spada: Never more!
Senza una disciplina personale, non c’è artista, non c’è scrittore, non c’è ingegnere; talento personale e santità sono votate allo scacco. Senza regola, non c’è capolavoro, non c’è vita contemplativa, non c’è elevazione mistica. È arrivato il momento di sbarazzarsi degli slogan faciloni che ricoprono il suolo putrescente di questo tempo, e di ritrovare il segreto degli antichi per diventare, non degli imbroglioni disonesti, ma dei saggi artigiani delle nostre vite. Non ricordo quale scrittore diceva: «Il genio consiste nel sedersi all’ora prefissata al proprio tavolo di lavoro».
Comunque bisogna ricordare – soprattutto per quanto riguarda l’ordine spirituale – il paragone stabilito da Charles Péguy tra le regole dure e le regole morbide, queste essendo più esigenti di quelle, perché impegnano l’uomo in una zona di profondo legame. È solo in questo senso, e non senza qualche apprensione, che proponiamo una regola di vita dell’anima.



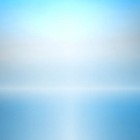



Nessun commento pubblicato